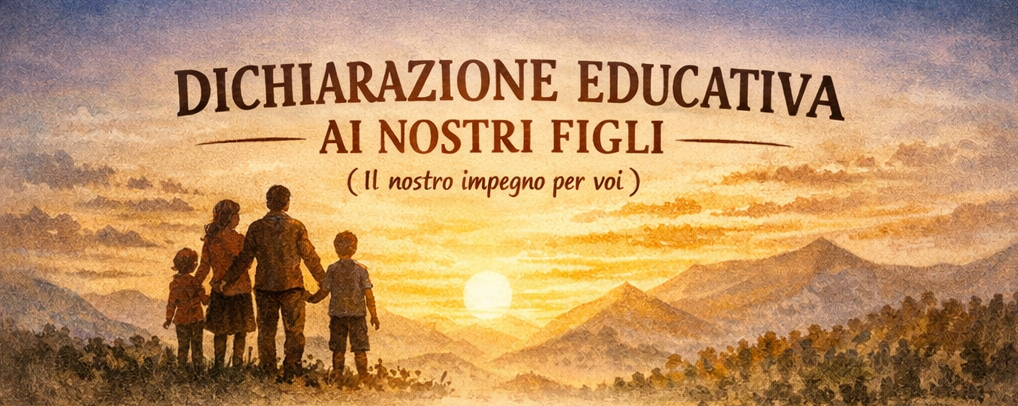Libertà, paura e il confine invisibile tra tutela e controllo
Una vicenda silenziosa, ambientata nei boschi dell’Abruzzo, è diventata in poche settimane oggetto di attenzione nazionale. Una coppia straniera vive con i propri tre figli vicino a Palmoli, in una abitazione isolata, priva dei servizi tradizionali, e si trova ora sotto indagine da parte della Procura dei Minori. Per molti è un caso di trascuratezza; per altri, al contrario, una scelta radicale e coerente. Per chi opera nel campo dell’istruzione parentale, rappresenta qualcosa di più profondo: un segnale che lo Stato è sempre più incline a varcare la soglia delle case per stabilire cosa sia “giusto” per i nostri figli.
Ogni qualvolta una famiglia opta per un percorso fuori dagli schemi — meno consumista, più autosufficiente, più libero — la reazione sociale è spesso di sospetto. I titoli parlano di “bambini senza scuola”, “case senza elettricità”, “famiglie isolate”. Dietro queste parole si cela non tanto la realtà quanto la paura del diverso. Una famiglia che decide di vivere in modo indipendente, di educare in libertà o di ridurre la propria impronta sulla terra, non è più vista come esempio di coraggio, bensì come minaccia all’ordine costituito. E così, al posto del dialogo, si impone il controllo; al posto della comprensione, la diffidenza.
L’istruzione parentale, riconosciuta dalla legge italiana, non equivale a abbandono, ma a responsabilità consapevole. Significa essere presenti ogni giorno nella crescita dei figli, costruire una “scuola diffusa” — in casa, nei parchi, nei viaggi, nelle relazioni. La maggior parte delle famiglie homeschooler non vive ai margini della società, ma ne è parte attiva, con reti educative solide e collaborative. Eppure, basta un caso estremo per gettare un’ombra su migliaia di genitori impegnati con dedizione e trasparenza. In questo cortocircuito si confondono autonomia educativa e rifiuto delle regole, e la libertà stessa viene accusata.
La Costituzione italiana attribuisce ai genitori la responsabilità primaria dell’educazione dei figli. Lo Stato ha un ruolo di garanzia,
non di sostituzione. Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo assistito a un’inversione di ruoli: famiglie costrette a giustificare scelte del tutto legittime, bambini allontanati “per prudenza”, tribunali che valutano stili di vita anziché reati. Quando in casi di separazione o divorzio uno dei genitori propone l’istruzione parentale e l’altro la scuola tradizionale, le sentenze quasi sempre pendono dalla parte dell’istituzione scolastica: non conta quanto bene possa dimostrare un genitore homeschooler il benessere dei figli, conta piuttosto la “sicurezza” dello status‑quo. È un segnale culturale, non solo giuridico: lo Stato si fida di più di se stesso che delle famiglie. Il messaggio che ne emerge è chiaro: puoi educare in libertà, ma solo fintanto che non metti in discussione l’ordine stabilito. Tuttavia, perché la libertà sia tale, deve poter esistere anche al di fuori della comodità del consenso.
Esistono oggi, all’interno del sistema scolastico stesso, numerose situazioni di reale abbandono educativo che spesso sfuggono all’attenzione degli enti preposti. Minori lasciati soli per ore davanti a schermi, esposti precocemente a contenuti inappropriati, immersi in ambienti privi di relazione e cura autentica. Allo stesso tempo, vi sono famiglie che vivono in condizioni di precarietà abitativa, senza dimora fissa o in continuo spostamento, i cui figli, pur risultando formalmente iscritti a scuola, di fatto non frequentano e non ricevono alcuna continuità formativa. In questi casi, il bisogno di intervento da parte dei servizi sociali è concreto e urgente. È fondamentale che le risorse e le energie delle istituzioni si concentrino sulle situazioni dove effettivamente sussistono rischi educativi e di tutela, distinguendo con chiarezza le scelte pedagogiche responsabili — anche quando non convenzionali — da contesti di vera trascuratezza o disagio.
È importante riflettere su una dinamica spesso sottovalutata: molte famiglie straniere — ma anche alcune italiane — che scelgono in Italia l’istruzione parentale, pur conoscendo perfettamente diritti e doveri, ignorano come funzioni il contesto culturale e istituzionale italiano. In altri Paesi, le procedure sono standardizzate e impersonali. In Italia, invece, molto dipende da come ci si presenta, da come si comunica, e da chi si ha di fronte. Conoscere la norma non rende immuni dalle pratiche: chi vive fuori dagli schemi deve agire con attenzione, misurare ogni passo, evitare esposizioni inutili. La trasparenza è valore, ma in certi contesti può trasformarsi in vulnerabilità. È un invito all’intelligenza situazionale: non basta avere ragione, serve saper operare nella realtà.
Dietro i titoli sensazionalistici c’è una questione più profonda: una società che fatica ad accettare la libertà come valore reale. Siamo abituati a delegare tutto — la salute, l’educazione, le scelte morali — e chi decidesse di assumersi la responsabilità diventa “pericoloso”. Eppure, sono proprio queste famiglie — spesso etichettate come “irresponsabili” — a incarnare la forma più alta di responsabilità: educano, nutrono, costruiscono, vivono con coscienza. Non chiedono privilegi; chiedono rispetto.
L’Italia non ha bisogno di più controllo. Ha bisogno di più fiducia, di più ascolto, di più alleanze tra istituzioni e famiglie. Le istituzioni devono imparare a collaborare con le famiglie, non a sospettare di loro. Le famiglie, a loro volta, devono conoscere i propri diritti e renderli visibili con rispetto e trasparenza. Libertà e sicurezza non sono antagoniste: sono due facce della stessa medaglia. La vera sfida è mantenerle in equilibrio. Alla fine, la questione non è dove vivano i bambini, ma chi ha il diritto di guidarli nella vita: i loro genitori o lo Stato?