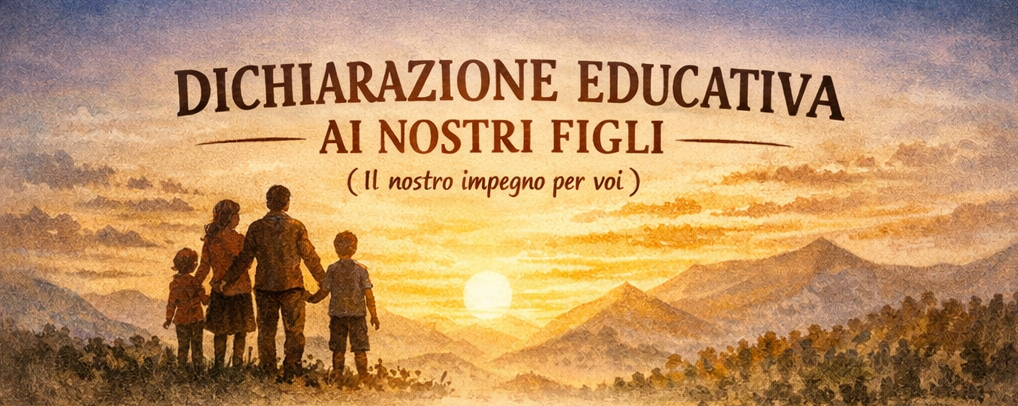L’ONU riafferma il diritto dei genitori a dirigere l’educazione dei figli: una conferma internazionale per la libertà educativa
Il recente rapporto delle Nazioni Unite, redatto dalla Relatrice Speciale sul diritto all’istruzione Farida Shaheed, rappresenta un documento fondamentale per chi si occupa di educazione nel XXI secolo. Pubblicato nel contesto della 59ª Sessione del Consiglio dei Diritti Umani (giugno–luglio 2025), questo testo è frutto di una visita sul campo negli Stati Uniti, ma le sue osservazioni risuonano ben oltre i confini americani.
Il documento va letto con attenzione da chi, come noi, lavora ogni giorno per costruire una cultura dell’apprendimento centrata sulla persona, sulla relazione e sull’autonomia. Le analisi contenute nel rapporto non solo mettono in luce le fragilità dei sistemi educativi centralizzati, ma riaffermano un principio essenziale: l’educazione appartiene alla comunità, e in primo luogo alla famiglia.
Il sistema scolastico statunitense: disuguaglianze strutturali e compressione dell’esperienza educativa
La fotografia scattata dal rapporto è nitida e impietosa. Pur riconoscendo la diversità e flessibilità dell’offerta educativa americana, la Relatrice Speciale evidenzia che il sistema riflette profonde disuguaglianze. Non si tratta solo di differenze tra scuole ricche e scuole povere: il problema è sistemico.
“L’istruzione negli Stati Uniti è caratterizzata da disuguaglianze radicate, in particolare per le comunità a basso reddito e marginalizzate.” (par. 7)
Il finanziamento basato sulla tassazione immobiliare locale alimenta un divario crescente tra le scuole: dove le famiglie hanno più mezzi, la scuola è meglio finanziata, attrezzata, supportata; dove i redditi sono più bassi, la scuola diventa spesso uno spazio di contenimento più che di crescita.
A ciò si aggiungono criticità gravi:
- standardizzazione soffocante dei percorsi,
- uso punitivo della disciplina che colpisce in modo sproporzionato le minoranze etniche,
- privatizzazione crescente che rischia di svuotare la funzione sociale dell’istruzione pubblica,
- assenza di una cultura della cura per il benessere psico-emotivo di studenti e insegnanti.
Il risultato è un sistema che, più che “educare”, tende a classificare, isolare, addestrare. Una scuola che spesso perde la sua anima, ridotta a gestione di dati e contenimento comportamentale.
Il ruolo dei genitori: non solo supporto, ma diritto originario
Uno dei passaggi più rilevanti del documento si trova al paragrafo 74, dove viene ribadito che:
“La Costituzione protegge il diritto fondamentale dei genitori di dirigere la cura, la crescita e l’educazione dei propri figli.”
Non è un dettaglio. È un’affermazione giuridica e culturale di enorme portata. Fa eco alla celebre sentenza Pierce v. Society of Sisters del 1925, emblema della visione secondo cui il bambino non appartiene allo Stato, ma alla sua famiglia, alla sua comunità affettiva ed educativa.
Questa posizione assume un significato ancora più forte nel contesto contemporaneo, segnato da:
- tentativi di centralizzare e uniformare i percorsi formativi,
- pressioni normative che scoraggiano ogni deviazione dagli standard imposti,
- narrazioni mediatiche che marginalizzano o ridicolizzano chi sceglie strade educative alternative.
L’affermazione dell’ONU, invece, sancisce con chiarezza che il primato educativo appartiene ai genitori, e che questo diritto è parte integrante del diritto umano all’istruzione
Homeschooling come possibilità riconosciuta e concreta
In questo quadro, non stupisce trovare nel rapporto un chiaro riconoscimento dell’istruzione parentale:
“In tutti i 50 Stati, i genitori possono legalmente istruire i propri figli a casa.” (par. 27)
Non è un passaggio secondario. L’homeschooling, da tempo in crescita anche in Europa, viene qui legittimato all’interno di un documento internazionale sui diritti umani.
Questo significa che l’educazione parentale non è una soluzione estrema, né un privilegio individuale, ma una delle tante modalità possibili per garantire l’adempimento del diritto all’istruzione in forme pluralistiche.
Per Fondazione Libera Schola, questa visione è coerente con la nostra esperienza concreta: progetti come Libere Ludere, i Learning Pods, i percorsi di apprendimento familiare o i viaggi educativi internazionali, nascono proprio da questa comprensione dell’educazione come fenomeno diffuso, incarnato e plurale.
Sicurezza scolastica: un’emergenza educativa e relazionale
Un altro tema centrale emerso dal rapporto riguarda la sicurezza nelle scuole. Non si tratta solo di sicurezza fisica — sebbene negli Stati Uniti siano documentati episodi gravi legati alla violenza armata — ma anche di sicurezza emotiva, psicologica, sociale.
“Molti studenti si sono detti insicuri, discriminati, non supportati nel loro ambiente scolastico.” (par. 61)
“I timori principali riguardano sparatorie, bullismo, isolamento, mancanza di supporto alla salute mentale.” (par. 62–65)
Questo solleva una questione cruciale: la scuola può davvero definirsi inclusiva, se non garantisce benessere relazionale?
Il diritto all’istruzione non è il diritto a stare in aula, ma a stare bene mentre si cresce, si apprende, si costruisce il proprio futuro.
In Italia, le condizioni sono diverse, ma non mancano segnali d’allarme: burnout studenteschi, crisi di ansia a scuola, diffusione precoce di dispositivi digitali e isolamento sociale. Serve una riflessione profonda su cosa significhi realmente “educare alla vita”.
Verso una pedagogia della fiducia: l’educazione come diritto e responsabilità condivisa
Nelle conclusioni del documento, l’ONU propone una definizione di educazione che ci è molto vicina:
“Proteggere il diritto all’istruzione significa più che assicurare accesso alle aule. Significa creare ambienti sicuri, inclusivi, solidali dove ogni bambino possa fiorire.” (par. 93)
Fiorire: è questo il verbo centrale. Un bambino non si istruisce, si coltiva. Non si prepara al futuro con competenze astratte, ma si accompagna nel presente con presenza, ascolto e significato.
L’educazione è — e deve tornare ad essere — relazione, esplorazione, possibilità.
Il compito di Libera Schola:
custodire e moltiplicare le forme della libertà educativa
Questo rapporto delle Nazioni Unite rafforza la nostra missione. Non siamo soli in questo lavoro: la libertà educativa ha fondamenta giuridiche, culturali e sociali profonde.
La nostra responsabilità è quella di renderle visibili e praticabili: creare spazi, tessere reti, costruire alleanze tra famiglie, educatori, professionisti e territori. Libera Schola continua a sostenere una visione dell’educazione come patrimonio vivo delle comunità umane.
Il bambino, ci ricorda il rapporto, non è una creatura dello Stato.
Ma è, e deve restare, un soggetto libero, guidato da adulti che hanno il diritto e il dovere di accompagnarlo con amore, visione e fiducia.